Gesualdo Bufalino, « Argo il cieco » (1984)
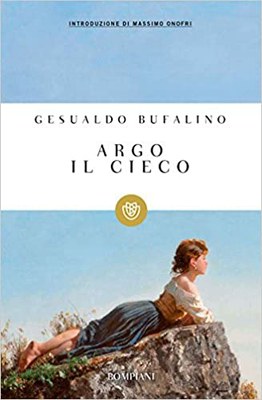
Pubblicato nel 1984, Argo il cieco è il secondo romanzo dello scrittore e poeta Gesualdo Bufalino. Nato a Comiso nel 1920, Bufalino divenne celebre come romanziere solamente nel 1981, in seguito alla pubblicazione della sua prima opera narrativa, Dicerie dell’untore, con la quale si aggiudicò nello stesso anno il Premio Campiello. Insegnante, uomo di vastissima cultura, egli si distinse come scrittore per il suo talento e come uomo per la sua discrezione, la sua riservatezza, l’umiltà.
Argo il cieco ovvero I Sogni della memoria è una sorta di diario-romanzo, in cui si intrecciano, inseriti in una cornice metanarrativa, ricordi, riflessioni, realtà, menzogne. L’io narrante, probabilmente alter-ego dell’autore, insegnante sulla sessantina, si ritrova durante un inverno piovoso a fare i conti con il suo trascorso in una stanza d’albergo della Capitale; egli ricostruisce in solitudine il ricordo della vita passata – più precisamente quello dell’estate del 1951 – riflettendo sul tempo che “fu”, su quel tempo che di certo ora non “è più” e forse, in un intreccio complicatissimo da parte dell’autore che gioca col limite tra ricordo e immaginazione, su un tempo che “non è mai stato”. È attraverso il passato remoto che ricordo e narrazione si dispiegano, nel medesimo istante: “Fui giovane e felice un’estate, nel cinquantuno. Né prima né dopo: quell’estate”. L’utilizzo del “fui” in apertura relega definitivamente la felicità ad un tempo passato, la costringe lì, tra le cose che non sono più, l’accosta alla giovinezza, in un rapporto che appare inscindibile, come se fossero l’una funzione dell’altra, entrambe necessarie per garantire la reciproca sopravvivenza.
L’io narrante ripercorre l’estate modicana, i suoi trent’anni; riporta scene di vita quotidiana, anche quelle più piatte, meno entusiasmanti; traccia il ritratto di alcuni personaggi della realtà cittadina, come ad esempio quello di don Alvise Salibba; disegna Modica, i suoi paesaggi, quella città-teatro che riprende forma nei suoi ricordi; rivive il calore rasserenante di alcune cicliche situazioni estive. Ma soprattutto egli parla di amori, e di amore. Quello per Maria Venera, ad esempio. L’amore è per Bufalino un qualcosa di molto intimo, personale, un moto che interessa colui che ama e nessun altro, apparentemente neppure l’oggetto stesso di questo amore: “L’amo, ma lei che c’entra, la cosa riguarda me”. Tutto avviene dunque nell’interiorità, in una dimensione privata; tutto si concentra sull’io narrante. Questo sentimento rappresenta inoltre per l’autore qualcosa di effimero, destinato a disgregarsi in seguito all’azione inevitabile e distruttrice del tempo; esso è dunque motivo di dolore, di sofferenza.
L’amore per Maria Venera è l’amore che prova ogni giovane, l’amore di ognuno di noi quando facciamo i conti con gli effetti di questo, con la gelosia, con l’attesa, con le nostre insicurezze infantili, quelle che siamo restii a confessare persino a noi stessi e che qui l’autore delinea, invece, senza mettere a tacere o frenare qualsivoglia pensiero, da quello più coerente a quello più sconclusionato. Bufalino descrive in questo suo romanzo una realtà molto semplice, attraverso una trama lineare, senza intrecci decisivi, che non colpisce se non in alcuni passaggi (come quello della gravidanza di Maria Venera, o quello della partenza di quest’ultima) che restano ad ogni modo molto equilibrati, mai eccessivi; non vi è nulla di tragico o di esageratamente drammatico nella narrazione; tuttavia, proprio per la sua semplicità, per il realismo della parte strettamente narrativa (e solo della parte narrativa), ogni lettore si riconoscerebbe nei moti dell’anima del protagonista (l’autore, si rivolge al lettore alla fine del romanzo come al suo “sosia e fedele caino”), ognuno ritroverebbe un po’ di sé in quelle caldi estati della propria città natale, vittima di un’infatuazione o di un qualsivoglia amore giovanile; vittima anche del ricordo, ricordo che se da una parte è per Bufalino l’unico mezzo di lotta contro l’oblio e di recupero dei valori umani, dall’altro è ciò che gli illusori meccanismi della memoria osannano e fanno apparire migliore rispetto al presente; di conseguenza, per l’autore come per ogni altro uomo, il ricordo diviene una culla per le angosce del tempo presente, una panacea, un meccanismo per difendersi dalle paure confrontandosi invece con un tempo e uno spazio conosciuti e familiari, un tempo sospeso e immune alla vecchiaia, eternamente giovane nella mente di ognuno di noi. Il protagonista è ancorato al ricordo, in esso si rifugia ritrovando una felicità ormai perduta nel presente; tinge il suo passato di un colore acceso, vivo, confortante. Leggiamo in apertura: “Perduta per timidezza l’occasione di morire, uno scrittore infelice decide di curarsi scrivendo un libro felice”; ma è la memoria, attraverso il complesso meccanismo di riedificazione del ricordo, a restituire una realtà felice o è piuttosto il passato ad esserlo stato davvero? È il libro in sé ad essere felice o il passato nella sua oggettività? La memoria agisce da filtro dei ricordi, li altera: rimuove i passaggi peggiori dell’esistenza e conserva i migliori; in tal modo, il ricordo, epurato dai suoi traffici più minacciosi, privato degli elementi più dannosi, restituisce una felicità che in parte non è mai esistita, restituisce una menzogna; la memoria si rivela pertanto la funzione psichica deputata a costruire il cosiddetto “sogno ad occhi aperti”. Di tutto ciò il protagonista prende coscienza durante il suo racconto. Così, se in prima istanza nella rievocazione del ricordo gli “amori non corrisposti” gli appaiono “i più comodi”, ben presto, dopo una riappropriazione da parte della coscienza non più solo delle sequenze della memoria ma anche delle sensazioni e delle emozioni effettive che questa fa riaffiorare attraverso la narrazione, quel suo entusiasmo iniziale si spegne e si trasforma in “Gli amori non corrisposti, Dio ce ne liberi! Bestia chi dice che sono i più comodi.”
Per quanto la trama sia essenziale, Argo il cieco è tutt’altro che un romanzo semplice e scorrevole. La specificità di Gesualdo Bufalino, così come del romanzo in questione, è il ricorso a tutta una serie di raffinati giochi linguistici; Bufalino, in un malinconico e a tratti sformato scorrere della narrazione, affida alla singola parola il ruolo di protagonista, dando vita ad una narrazione fortemente evocativa, in cui tutto, pur procedendo in maniera irregolare, si fonde in armonia. Il lettore si trova dunque dinnanzi ad un’opera molto impegnativa, tantopiù che l’autore impiega un linguaggio ricercato, pregiato nelle sue scelte lessicali, in cui arcaico e moderno si mescolano, coesistono. Si tratta di una scrittura che fa del pastiche linguistico il suo tratto distintivo, utilizzato per realizzare una prosa in grado di muoversi tra realtà presente, ricordo, inganno e flusso di coscienza. Quest’ultimo è l’elemento che rende più articolata la narrazione: l’autore vi inserisce tutta una serie di riflessioni, talvolta spezzate, intrise di frasi lapidarie (“Alvise, che la terra ti sia leggera”) e lo fa senza mai fermarsi, come a riprodurre in maniera del tutto fedele il flusso ininterrotto e disparato del pensiero.
Lo stile dell’autore traspare sin dall’incipit; leggiamo infatti: “[…] Sennonché, più il racconto va avanti, e si trucca di fiabe, e formicola di luminarie, più lascia varchi fra le righe al soffio del nero presente. Non resta allo scrittore che differire sine die la salute, pago d’aver cavato dall’avventura qualche momentanea lusinga ad amare l’inverosimile vita…”; capiamo dunque sin da subito che il testo richiederà un certo sforzo intellettuale se si vorrà procedere ad una buona analisi; il lettore deve far fronte ad un linguaggio che la critica ha celebrato e detestato al tempo stesso per la sua ostichezza. A questa introduzione che abbiamo riportato, Bufalino dà un titolo (i suoi titoli sono sempre molto esplicativi, ogni capitolo ne presenta uno che ne riassume i passaggi fondamentali, ad esempio “Litania delle belle notti. E come fu che si giunse a quell’estate attraverso varie stagioni e varie corrugazioni del sentimento”); la chiama “Locandina delle intenzioni” e termina così: “Partire da questa ipotesi. Poi si vedrà che succede”; questo finale è emblematico: l’autore dialoga infatti continuamente sia col pubblico che col testo e concepisce l’opera come un qualcosa “da farsi”. Il lettore ha dunque la sensazione di partecipare alla scrittura del romanzo. Bufalino si rivolge spesso al suo pubblico di lettori e lo tiene al corrente delle sue scelte poetiche, delle sue esitazioni, inserendo lunghe considerazioni sul testo, come se lo stesse scrivendo sul momento e soprattutto come se non avesse una meta. Non è così semplice seguire la direzione dell’autore: lo scopo in certi momenti metanarrativi sembra sfuggirli di mano, sembra non essere chiaro neppure a lui. Si tratta evidentemente di meccanismi retorici: il fine ultimo è chiarissimo a Bufalino, che ne delinea i tratti senza ricorrere ad ambiguità in due momenti: all’inizio e alla fine. Egli scriverà “scrivere è stato per me solamente un simulacro del vivere, una pròtesi del vivere”; la scrittura è dunque un modo per ritrovare un barlume in quella stanza e in quella vita ormai troppo buie, nell’esistenza di un Argo ormai cieco, che per il suo stato non ha più modo di far entrare alcuna luce nei suoi occhi. Argo è un personaggio mitologico: è Argos Panoptes, per l’appunto “Argo che tutto vede”; era, Argo, secondo la mitologia greca un gigante dai cento occhi: mai tutti chiusi, neppure per dormire. Qui Argo non ne apre più nemmeno uno: la luce chiara di Modica non arriva più nell’oscurità di quella camera d’albergo, in quella Roma che appare ormai al protagonista “deserta di luna”: “Qui la mia luna non giunge, la mia iblea, agricola luna. La cerco senza speranza…”. La luna è un riferimento letterario importante, che ritroviamo come tema classico in Virgilio ad esempio, che ritroviamo anche in Leopardi o negli Illuministi come elemento che rischiara le cose e rischiara le idee, che porta luce nella notte degli uomini; ma la luna questa volta non fa capolino nel presente del protagonista, nell’ombra dell’esistenza di un uomo di sessant’anni “sicofante e baro, […] bibliotecario del nulla, guardiano a spasso d’una incenerita Alessandria”. Argo può trovare luce solamente nel ricordo a cui resta saldato, vincolato ad un destino che fu, consumato dal destino che è, cieco verso ciò che sarà.
Vi è in una certa misura, attraverso la scrittura, una presa di coscienza da parte del protagonista: se da un lato egli scrive “a scopo geriatrico”, per trovare sollievo, per trovare un’ancora, un qualcosa che lo tenga legato alla vita, dall’altra si rende conto di essere forse fissato ad essa dal lato sbagliato; leggiamo infatti alla fine: “Mi sembra certe volte di invecchiare incatenato alla mia memoria, come invecchiano nelle caverne i draghi custodi accanto al tesoro. Senza che mai sopraggiunga da fuori un solo paladino a sfidarli. Poveri, rugosi draghi, dal corpo a scaglie stipiti d’ulivo, incarcerati nel buio, in attesa che una durlindana gli luccichi innanzi e paghi loro la pazienza! Mentre gli anni passano…” L’attaccamento all’idea di un passato felice non permette al protagonista di realizzare che una nuova felicità è possibile nonostante tutto e nonostante la funzione giovinezza-felicità non trovi più una sua effettività. Scrivere diventa un modo per prendere atto del fatto che gli umori negativi sono diversi e uguali in ogni momento della vita; se l’obiettivo iniziale della scrittura era quello di arricchire con un po’ di felicità una vita di cui il protagonista non è più soddisfatto, abbellendola col mito di una giovinezza felice, a costo di inventarne una, alla fine il traguardo pare essere la possibilità, in questa disperazione esistenziale, di liberarsi dalle catene del passato, dalla menzogna della memoria che altera il ricordo e che fa credere che quella felicità passata, glorificata e manipolata, non sia più possibile. La fine del romanzo potrebbe essere interpretata così come l’unico vero inizio: è ora, per il protagonista, di liberarsi dagli ingannevoli ricordi e dall’inganno di se stesso: “Inventiamoci un passato proposi a Non-so-come-si-chiama quella notte di ferragosto. Inventiamoci un futuro, propose”.
Pour citer cette ressource :
Serena Mercuri, Gesualdo Bufalino, Argo il cieco (1984), La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), septembre 2020. Consulté le 10/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/italien/litterature/bibliotheque/gesualdo-bufalino-argo-il-cieco-1984



 Activer le mode zen
Activer le mode zen